I Norovirus (NoV) sono considerati la causa principale di patologie gastroenteriche nell’uomo di origine non batterica. Spesso fonte di focolai a carattere epidemico, secondo le stime dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi, ogni anno nel mondo si verificano 685 milioni di infezioni da NoV, di cui 200 milioni tra bambini al di sotto dei 5 anni, di cui circa 50.000 fatali soprattutto in Paesi in via di sviluppo. Le spese sostenute per le cure mediche e l’impossibilità di chi è malato di recarsi sul luogo di lavoro causano ogni anno ingenti danni economici, intorno ai 60 miliardi $ a livello globale. Il virus è estremamente virulento e viene trasmesso attraverso il contagio diretto tra le persone o tramite la contaminazione crociata degli alimenti.
Vista l’importanza che tale patogeno riveste nella salute in ambito umano, e alcune segnalazioni di presenza di NoV nel serbatoio animale, un gruppo di ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) coordinati dalla dott.ssa Maria Serena Beato, medico veterinario dirigente del Laboratorio di virologia diagnostica, ha condotto uno studio, finanziato dal Ministero della salute (RC 12/15), per valutare la presenza di NoV nella popolazione suina del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. I risultati sono stati recentemente pubblicati su Scientific Reports.
Circolazione del Norovirus negli allevamenti di suini

I Norovirus (NoV) sono considerati la causa principale di patologie gastroenteriche nell’uomo di origine non batterica. Poiché i NoV suini sono correlati geneticamente ai NoV umani, si è ipotizzato un possibile ruolo zoonosico di questa specie. Uno studio dell’IZSVe ha quindi indagato la presenza di norovirus (NoV) nella popolazione suina del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
La scelta di indagare la presenza di NoV nel suino deriva dalle diverse segnalazioni di NoV effettuate in quest’ospite sin dagli anni ‘90 in tutto il mondo. Poiché i NoV suini sono correlati geneticamente ai NoV umani, si è ipotizzato un possibile ruolo zoonosico di questa specie. In aggiunta, il recente ritrovamento di genotipi tipicamente umani in carne cruda al dettaglio importata, ha destato preoccupazione sul ruolo del suino come possibile fonte di nuovi ceppi virali ricombinanti trasmissibili direttamente all’uomo.
Nella prima fase della ricerca (2017) sono stati raccolti al macello 79 campioni di feci da animali provenienti da 76 diversi allevamenti distribuiti nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e appartenenti a diversi indirizzi produttivi: allevamenti da ingrasso, riproduzioni a ciclo aperto e a ciclo chiuso. Nella seconda fase (2018-2019) sono stati raccolti 225 campioni in 74 differenti allevamenti della sola regione Veneto, concentrandosi sugli allevamenti da ingrasso, sia a ciclo aperto che ciclo chiuso. In totale sono stati analizzati 304 campioni di feci.
Nel complesso sono risultati positivi al Norovirus 31 campioni: 2 in Veneto durante la prima fase e 29 nella seconda fase. La maggior parte dei positivi è stata riscontrata in animali con un età superiore ai 90 giorni mentre le aziende positive sono state 24, suddivise tra 18 allevamenti da ingrasso e 6 da riproduzione a ciclo chiuso.
Divergenza genetica del Norovirus in Veneto
La genotipizzazione dei campioni positivi ha consentito di identificare la co-circolazione di due genotipi distinti GII.P11 e GII.P18, di cui quest’ultimo costituisce la prima segnalazione in Italia e la terza in Europa dopo otto anni. I ricercatori dell’IZSVe hanno sviluppato un metodo di sequenziamento che ha permesso di analizzare porzioni estese dell’RdRp, nonché di generare la prima sequenza italiana del gene VP1 di NoV del suino. Le analisi molecolari e filogenetiche condotte hanno consentito di rilevare una straordinaria diversità genetica presente in Veneto all’interno di ogni genotipo identificato, individuando gruppi distinti con una distanza genetica significativa tra loro. Va sottolineato che ceppi così diversi hanno circolato in un territorio limitato alla sola regione Veneto in un arco temporale di soli tre anni (Figura 1).
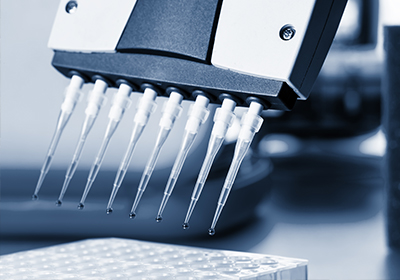
Tra il 2017 e il 2019 sono stati analizzati in tutto 304 campioni, riscontrando 31 positività. La genotipizzazione dei campioni positivi ha consentito di identificare la co-circolazione di due genotipi distinti GII.P11 e GII.P18, di cui quest’ultimo costituisce la prima segnalazione in Italia e la terza in Europa dopo otto anni. Le analisi molecolari e filogenetiche condotte hanno consentito di rilevare una straordinaria diversità genetica presente in Veneto.
Tale variabilità è stata riscontrata anche a livello amminoacidico. Infatti i ceppi GII.P11 italiani presentano 18 mutazioni uniche, non presenti in nessun altro GII.P11 di cui sia disponibile la sequenza nelle banche dati, mentre i ceppi GII.P18 ne presentano tre. L’impatto di queste mutazioni sulla struttura della proteina non è stato per il momento indagato; tuttavia sulla base di un’analisi dell’entropia delle sequenze nucleotidiche eseguita per determinare quali di queste mutazioni potessero essere significative. L’analisi dell’entropia infatti stabilisce quali posizioni all’interno di una sequenza nucleotidica siano più predisposte al cambiamento e quali meno. Delle 18 mutazioni uniche presenti nei ceppi GII.P11 diverse presentano una alta entropia, caratteristica quindi da monitorare in futuro.
Continuare il monitoraggio per comprendere l’interazione suino-uomo
La grande variabilità genetica riscontrata in un lasso di tempo breve e in un territorio poco esteso sicuramente era inaspettata e pone diverse domande che per ora rimangono aperte. Infatti ad oggi non è possibile stabilire se tale diversità genetica dipenda da continue introduzioni esterne di NoV, dovute a movimentazioni e importazioni, o se sia il risultato di un’evoluzione costante all’interno del territorio oggetto dello studio. Se quest’ultima ipotesi fosse avvalorata, significherebbe che i NoV circolano estesamente già da tempo.
La circolazione dei NoV nel serbatoio animale aumenta la probabilità di eventi di ricombinazione nel serbatoio animale stesso ma anche tra ospite animale e ospite umano. Il contatto suino-uomo infatti avviene in maniera costante mediante operatori sanitari e allevatori che non ricevono una sorveglianza sanitaria adeguata come categoria di lavoratori, nell’ambito della prevenzione, in un’ottica di One-Health.
I dati prodotti necessitano di un follow-up, infatti i ricercatori dell’IZSVe sono impegnati al fine di ottenere sostegno per continuare questa linea di ricerca. È necessario infatti continuare un monitoraggio in campo per individuare il potenziale ingresso di nuove varianti di NoV nel serbatoio animale e/o l’evolversi di quelle già riscontrate. Molto però deve essere investito sull’aggiornamento di mezzi e metodiche per caratterizzare i NoV animali e per riuscire a costruire un confronto robusto con le varianti umane, utile a comprendere il potenziale zoonosico e il ruolo del suino.
Leggi l’articolo su Scientific Reports »






![Febbre Q. Problema zoonosico o zootecnico? [Video webinar]](https://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2025/03/febbre-q-problema-zoonosico-o-zootecnico-video-webinar-500x383.jpg)

